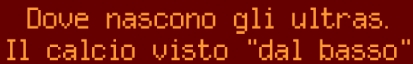di
Valerio
Marchi
tratto
da
"Carta" 9/15 settembre 2004
La
sindrome
del beduino:
L'amico
del mio amico è mio amico
Il
nemico del mio amico è mio nemico
L'amico
del mio nemico è mio nemico
Il
nemico del mio nemico è mio amico
Dove
nascono gli ultras. Il calcio visto «dal basso»
di
Valerio Marchi
Stretto
tra i palazzi che si allungano fino a sbirciare nel terreno
di gioco, con
la sua forma squadrata e gli spalti schiacciati sul campo,
lo stadio Marassi
di Genova manifesta nella sua dislocazione e nella sua
struttura la propria
natura esplicitamente cittadina e monodisciplinare, da
indiscussa cattedrale
dell’antica e nobile tradizione calcistica genovese.
A
Marassi, come in tutti gli altri stadi dedicati unicamente
al calcio, per
dieci mesi su dodici va in scena il medesimo spettacolo:
niente meeting
di atletica, niente concerti rock o pop, ma solo e soltanto
il conflitto
ludico-simbolico tra contrapposte comunità.
Correndo
indietro nei secoli, oltre quel processo di regolamentazione
che si sviluppa
in Gran Bretagna nel corso dello scorso secolo, oltre le
suddivisioni artificiose
tra «soccer» e «rugby» e «football»,
tra palla tonda e palla ovale, tra uso dei piedi e uso delle
mani, troviamo
infatti alla base di questi sport moderni un gioco
altomedievale in cui
la figura dell’attore coincide con quella dello spettatore
e, ancora oltre,
con buona parte dei maschi adulti in ogni singola comunità,
che
troviamo ben rappresentato nell’«hurling over the country»
dell’Inghilterra del XIV secolo.
Queste
sfide tra comunità – che possono essere rappresentate da
paesi differenti,
ma anche da altre forme di aggregazione, quali gli scapoli
contro gli ammogliati
dello stesso paese, come avveniva nella cittadina britannica
di Scone –
si svolgono di solito nelle ricorrenze religiose o
comunitarie e si caratterizzano
per l’assenza di regole certe e uniformi sulla durata
dell’incontro [che
può raggiungere anche le 72 ore], sul perimetro di gioco
[che spesso
coinvolge l’intero territorio], sul numero dei partecipanti
[trenta, cinquanta
o più giocatori per parte], per il livello di violenza e il
«tutto
è permesso» che regola gli scontri in campo. L’agone assume,
anzi, caratteristiche tali da essere considerato dalle
autorità
una vera forma di teppismo, un’aperta manifestazione di
quell’aggressività
e sfrenatezza popolare cui si vuol porre un freno attraverso
la civilizzazione
forzata dei costumi, oltre che una forte distrazione dal
gioco marziale
del tiro con l’arco. Da un lato la violenza incontrollata
del calcio, dunque;
dall’altro la tensione calibrata, fredda e funzionale [alla
guerra] del
tiro con l’arco: nelle scelte delle autorità, che
giungeranno nel
1314 a porre fuorilegge l’«hurling over the country», si
possono
scorgere i primi segnali di quel processo di coartazione
culturale delle
classi subalterne, e più generalmente dei giovani d’ogni
classe
e ceto, che segnerà i secoli successivi e di cui la
creazione del
concetto di «sport» sarà parte integrante [Elias-Dunning,
1989].
Guerra
o competizione?
La
storia del calcio, dal XIV secolo ad oggi, coincide dunque
con la storia
della sua rielaborazione da conflitto simbolico tra comunità
a competizione
sportiva tra atleti, della sua progressiva regolamentazione
secondo i dettami
del nuovo ordine che, a partire soprattutto dalla seconda
metà del
XVIII secolo, verrà posto in opera prima contro le
turbolenze dei
giovani delle classi superiori e quindi, con l’allargamento
del tempo libero
e la trasformazione dei mezzi di produzione, contro quelle –
ben più
gravi – delle classi subalterne e delle loro «barbare e
sfrenate»
fasce giovanili.
Al
momento della nascita del calcio modernamente inteso [Londra
26 ottobre
1863: fondazione della Football Association] troviamo
infatti una situazione
perfettamente regolamentata, almeno per quel che avviene in
campo. Differente
è la situazione sugli spalti, ove le due contrapposte
comunità
che di volta in volta formano il pubblico – di matrice
prevalentemente
«working class» – continuano a essere pervase dallo spirito
originario dell’«hurling», partecipando attivamente
all’incontro
nelle forme spesso turbolente della tradizione contadina e
operaia.
Tra
il 1895 e il 1915 la Football Association assume 117
provvedimenti disciplinari
contro squadre i cui sostenitori si sono macchiati di
«disordini
o comportamenti scorretti», tra cui risse, attacchi contro
arbitri
e giocatori della squadra avversaria, atti di vandalismo
contro impianti
sportivi e mezzi di trasporto. A volte le turbolenze sono
tali da trasformarsi
in scontri di piazza: dopo il match tra Greenock Morton e
Port Glasgow:
città paralizzata per molte ore, negozianti barricati nelle
botteghe,
diciannnove poliziotti all’ospedale e nove tifosi in galera
[Durining-
Murphy- Williams 1988].
Anche
fuori dalla Gran Bretagna – in Italia, per esempio – si
inizia ad assistere,
nel XX secolo, ai primi casi di turbolenza calcistica: risse
[Genoa-Andrea
Doria, 1902], invasioni di campo [Juventus-Genoa, 1905],
sassaiole contro
l’abitro e intervento dei carabinieri [Andrea
Doria-Internazionale, 1912],
incidenti fuori dagli stadi [Milan-Andrea Doria, 1913;
Lazio-Juventus Roma
e Internazionale-Casale, 1914], colpi di pistola tra tifosi
[Spes Livorno–
Pisa sporting club, 1914].
Le
due guerre mondiali, con tutto quello che avviene tra l’una
e l’altra,
sembrano modificare di poco l’approccio del pubblico al
calcio, che è
nel frattempo diventato un vero e proprio spettacolo di
massa. Negli anni
Cinquanta troviamo, sul fronte delle turbolenze, una
situazione per molti
versi simile a quella di quarant’anni prima: in Gran
Bretagna, come in
Italia e nel resto dell’Europa calcistica, si registrano
scontri tra tifoserie
e con le forze dell’ordine, invasioni di campo, aggressioni
ad arbitri
e giocatori. In Inghilterra la Football Association registra
238 incidenti
tra il 1946 e 1959, mentre in Italia si assiste a una
escalation che, a
partire dalla metà degli anni Cinquanta, assume anche forme
fino
ad allora inedite quali le sassaiole contro i pullman delle
squadre avversarie
e le aggressioni contro giornalisti e dirigenti presenti in
tribuna.
Gli
anni cinquanta
In
questi episodi di turbolenza, si registrano atti e
comportamenti che ritroveremo,
con le dovute differenze, nel movimento ultrà: eppure,
nonostante
l’oggettiva gravità di molti episodi, la violenza legata al
calcio
non viene ancora considerata un’emergenza sociale né viene
riservato
al tifoso il ruolo di Folk devil, come avverrà con gli
ultràs.
Per
comprendere compiutamente questo diverso approccio delle
autorità
e del sistema dei media alla questione della violenza
calcistica si deve
infatti tener conto non soltanto dell’aumento quantitativo e
qualitativo
degli incidenti che accompagna la nascita e l’elspansione
del movimento
ultrà, ma soprattutto delle differenti peculiarità
conflittuali
del «tifoso turbolento» e dell’ultrà.
Diversamente
da quel che avverrà a partire da dieci anni più tardi, le
violenze che animano gli stadi d’Europa fino agli anni
Cinquanta sembrano
raccordarsi soprattutto alla sfera comportamentale del gioco
originario
e, ancora oltre, alle tradizionali turbolenze ritualizzate
delle classi
subalterne preindustriali [dal carnevale alle feste del
Misrule] delle
campagne inglesi del XVII e XVIII secolo [Gillis 1981],
valvole di sfogo
attraverso cui la conflittualità popolare veniva incanalata
e resa
innocua.
Allo
stesso modo, in un periodo – quale l’Italia degli anni
Cinquanta – in cui
ogni forma di dissenso o di conflittualità politica viene
violentemente
contrastata, la turbolenza dei tifosi di calcio è sì
combattuta,
ma non genera sindromi ansiose: il conflitto sociale –
quello «vero»,
che terrorizza l’establishment – passa ancora altrove,
attraverso le lotte
contadine e operaie e le loro organizzazioni politiche e
sindacali.
Eppure,
qualche piccolo segnale di mutamento nella «weltanschauung»
collettiva del tifoso si coglie già in questi anni
Cinquanta, quando
per esempio diminuiscono gli scontri tra tifoserie avverse e
aumentano
a dismisura le violenze contro arbitri e dirigenti; in
qualche modo, contro
le «istituzioni» dell’ormai affermato «show-biz»
calcistico. Primi, vaghi segnali di nuove forme conflittuali
che, pur restando
nell’ambito del calcio, riusciranno, a partire dagli anni
Sessanta, a esprimere
valenze più generali fino a conformarsi in una vera e
propria cultura
antagonista.
L’Upton
Park è lo storico stadio della squadra east-ender del West
Ham United;
ma, soprattutto, è uno dei luoghi che ha visto nascere e
svilupparsi,
verso la fine degli anni Sessanta, una cultura antagonista
destinata a
oltrepassare la Manica e a diffondersi velocemente in tutti
gli stadi d’Europa:
quella degli hooligan calcistici.
L’attuale
hooliganismo nasce infatti nel corso del campionato inglese
1967 – 1968,
quando «Alleanze ad hoc tra gruppi di adolescenti e di
ragazzi dei
quartieri e delle periferie operaie iniziarono a rivendicare
le curve dei
campi di calcio come territori propri e, in modo più
preordinato
di prima, a escludere da queste zone sia gli spettatori più
anziani
che i giovani sostenitori di squadre avversarie»
[Dunning-Murphy-Williams
1998].
Il
controllo del territorio
Questo
senso aggressivo del territorio è secondo le tesi della
scuola sociologica
di Leicester, frutto di fattori prettamente socioculturali:
questi giovani
«provengono dagli strati più bassi della classe operaia,
vivono
una comune condizione di disagio e marginalità sociale e
riproducono
nei gruppi hooligan l’appartenenza al proprio quartiere o al
proprio rione.
Il loro comportamento violento si spiega col fatto che hanno
fatto proprio
lo stile maschile violento tipico della cultura di vita
dello strato operaio
da cui provengono» [Roversi 1992].
Basta,
del resto, attraversare le zone del North Bank londinese più
periferico,
conoscerne la lunga storia di disoccupazione e di isolamento
politico-culturale,
per comprendere i motivi dell’altissimo livello di
conflittualità
sociale che gli «hools» inglesi hanno manifestato fin dagli
esordi e che, perpetuandosi [pur se in termini spesso
differenti] nel tempo
e in ogni possibile contesto europeo, hanno reso questa
cultura una delle
più attrezzate agenzie di conflitto sorte negli ultimi venti
o trent’anni,
in grado di interpretare – e a volte di anticipare –
dinamiche sociali
ben più vaste e articolate. Nei suoi trent’anni di vita, il
movimento
ultrà ha in breve dimostrato di essere una perfetta cartina
di tornasole
delle tendenze comportamentali in atto nella società,
ponendosi
come un inevitabile banco di prova per chiunque intenda
affrontare quella
che viene definita – con una certa dose di approssimazione e
d’ipocrisia
– la «questione giovanile».
Rispecchiando
alla perfezione il superamento del dato anagrafico
nell’ambito delle sfere
sociocomportamentali tradizionalmente riconducibili ai
«modelli giovanili»,
la cultura ultrà supera infatti ogni limitazione per andare
a coprire
una vasta fascia d’età, dalla prima adolescenza
[dodici-tredici
anni] alla piena maturità [quaranta e oltre]. Parlare degli
ultrà
non significa dunque parlare automaticamente di «giovani»,
pur se il movimento è composto prevalentemente da ragazzi e
da ragazze.
La
caratteristica principale di questa cultura non è il dato
anagrafico
– non si è alla presenza del tipico «peers group» –
ma quello comportamentale: da Mosca a Lisbona, da Atene a
Glasgow, l’ultrà
trova un comune denominatore non nell’età, ma nel senso di
contrapposizione
verso ogni forma di autorità costituita [da quelle sportive
a quelle
politico-istituzionali]. Unico, vero collante di un
movimento, per altri
versi frammentato, è il rifiuto di ogni forma di controllo
da parte
di altri, dalle società sportive [da cui la contrapposizione
con
i club riconosciuti e coordinati dalle società stesse] alle
forze
di polizia [considerate una «tribù avversaria»].
Una
seconda caratteristica comune a tutto il movimento è
rappresentata
dai forti sentimenti comunitari che lo animano e che si
manifestano soprattutto
nelle valenze assegnate alla curva: da semplice contenitore
di spettatori
a luogo sacro e inviolabile, da difendere contro ogni
possibile invasione
di tifosi avversari [il «take an end» di britannica memoria]
o dagli sconfinamenti della «blue line gang» [ovvero, nello
slang dei ghetti di Los Angeles, l’unica gang metropolitana
dotata di lampeggiatori
azzurri], in cui atteggiamenti e comportamenti vengono
regolati da leggi
proprie.
Nella
cultura ultrà il senso conflittuale si coniuga con questa
visione
dei rapporti di curva: il movimento si autorappresenta come
una serie di
comunità che si aggregano intorno a un ideale – la squadra –
e a
un territorio liberato, portatrici di una necessità di
aggregazione
che si manifesta non soltanto all’interno del gruppo, ma
anche attraverso
una rete di amicizie che va oltre la comunità di
appartenenza. Nel
movimento, questo duplice atteggiamento diviene esplicito
nei rapporti
tra differenti tifoserie, nella capacità di creare rapporti
con
«gli altri» in positivo e in negativo; nei gemellaggi come
nelle rivalità.
La
sindrome del beduino
Nonostante
l’ambivalenza insita in questo comportamento, che viene
definito di «sindrome
del beduino» [Harrison 1974], la cultura ultrà è invece
tradizionalmente associata soprattutto al meccanismo
dell’amico-nemico,
alla percezione dell’altro come presenza inevitabilmente
ostile. Come sempre
avviene nel rapporto tra cultura dominante e sottoculture,
anche in questo
caso un atteggiamento insito nel nostro modello di sviluppo
culturale e
sociopolitico viene dunque «scaricato» sul Folk devil di
turno
[Marchi 1994]: a essere profondamente intriso di xenofobia
non è
specificatamente il movimento ultrà, ma il nostro modello
sociale
nella sua interezza, soprattutto istituzionale; e la curva
rende semplicemente
[e ingenuamente] più esplicito, più grossolanamente
«visibile»
quel che nelle istituzioni e nella cultura dominante è tanto
più
grave quanto più sfumato.
Nelle
proprie caratteristiche principali, la cultura ultrà si
manifesta,
insomma, come un movimento di resistenza contro due processi
sociali: quello
del progressivo controllo politico dei comportamenti e
quello di mercificazione
del football, inteso non come puro gioco ma come luogo
sociale in cui si
concentrano interessi e conflitti di natura sia economica
che culturale.
In
questo contesto, risulta evidente come l’interazione tra
l’agire sociale
e l’agire «di curva» finisca per rappresentare un rapporto
di scambio politico bidirezionale, basti pensare alla
contaminazione tra
i linguaggi delle curve e quelli, ad esempio, dei cortei.
Specialmente
in Italia, per le caratteristiche che il movimento assume,
si registra
una forte interazione tra curva e dinamiche sociopolitiche.
Il gruppo ultrà
nasce, infatti, appropriandosi delle forme organizzative e
dei linguaggi
dei modelli politici antagonisti dei primi anni Settanta.
Per Antonio Roversi
sono tre gli elementi che contribuiscono alla nascita del
fenomeno: «Autonomia
dalla tutela paterna, modelli para-politici di coesione del
gruppo, assimilazione
per via imitativa delle forme inedite di tipo hooligan»
[Roversi
1992], e con essi di inconsapevole ma esplicita capacità di
interpretare
e rielaborare, in forme simboliche, la conflittualità
sociale.
Nato
come simulacro, come uno slittamento di scenario nell’ambito
dei conflitti
di classe, con la rottura del rapporto tra conflittualità
giovanile
e sfera politica maturata a partire dalla fine degli anni
Settanta, il
movimento ultrà si ritrova però a sopravvivere al proprio
modello originario. E quel che agli inizi si candidava a
essere un «simulacro
simbolico» [Dal Lago 1990] del conflitto politico, si
ritrova a dover
interpretare il ruolo di principale, se non unica, agenzia
antagonista
di massa.
Considerati
da giovani e meno giovani sempre meno adatti, spesso
addirittura mistificanti,
i codici della politica lasciano il passo a nuove forme di
conflitto che,
confermando le capacità divinatorie delle sottoculture
giovanili,
si tingono di quei toni impolitici e a tratti teppistici che
rappresentano
da sempre la realtà di strada [Humpries 1995].
Tratto
da «La sindrome di Andy Capp cultura di strada e
conflitto giovanile».
Ringraziamo autore ed editore
VAI
A:
GO
TO: